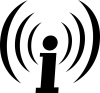Quarant'anni fa, il 17 maggio 1972, il commissario Luigi Calabresi veniva ammazzato sotto casa, a Milano. Il principale responsabile della morte di Giuseppe Pinelli, l'anarchico defenestrato dalla Questura di Milano pochi giorni dopo la strage di piazza Fontana, finirà i suoi giorni sul marciapiede di via Cherubini, alle 9.15 del mattino. Non un infarto, non un incidente, ma due proiettili lo costringeranno a dire addio alla carriera, alla pensione e alla vecchiaia. Il commissario Finestra sopravviverà perciò meno di tre anni alla sua vittima.
L'omicidio del commissario Calabresi suscitò scalpore in tutto il
paese, ma solo i suoi colleghi, i suoi datori di lavoro e coloro che
godevano della sua protezione lo compiansero. Tutti gli altri, ovvero la
stragrande maggioranza della popolazione, no. Non lo pianse nessuno.
«Hanno ammazzato l'assassino di Pinelli? Ben gli sta!»: questa fu la
sensazione più diffusa all'epoca. Quella più immediata almeno, quella
viscerale, scevra da ogni calcolo politico. Ma la politica, si sa, è una
tara difficile da eliminare. Si annida, si radica e si espande ovunque.
Così, subito dopo la morte di Calabresi, spuntarono fuori leader ed
aspiranti leader di movimento che iniziarono a brontolare, a storcere il
naso, a frenare gli entusiasmi. Evidentemente l'idea che dei singoli
individui potessero uscire di casa, cercare il nemico e farlo fuori
senza attendere la grande sera collettiva, era intollerabile. Si
rischiava di rendere superflui partiti e assemblee, leader e comitati.
«Non gioite, sono stati i servizi segreti!», «Non brindate, è un
pretesto per favorire la repressione!», «Non ridete, non è merito della
lotta di massa!». In nome della politica, della strategia, della tattica
— tutte cose detenute dai vari racket militanti — veniva proibita o
ridicolizzata l'esultanza dinanzi all'eliminazione di uno dei più
spietati nemici del movimento.
Un'azione esemplare, che parlava da sé, che non aveva bisogno di
alcuna giustificazione e spiegazione. E infatti l'omicidio Calabresi,
che secondo molti aprì l'assalto armato degli anni 70, non conobbe alcun
marchio di fabbrica, non si identificò con alcun logo. A detta di
alcuni, una rivendicazione circolò negli ambienti sovversivi ma venne
cestinata da tutti: impensabile anche solo da prendere in
considerazione. Comunque sia, foss'anche grazie alla censura di
movimento e nonostante le controverse successive condanne giudiziarie di
alcuni esponenti di Lotta Continua, resta il fatto che l'omicidio
Calabresi è sempre stato considerato privo di paternità, figlio di NN,
anonimo. Partorito dalla selva oscura. Solo ciò che non è proprietà di
nessuno può appartenere a tutti.
Quarant'anni dopo, il 7 maggio 2012, Roberto Adinolfi è stato
gambizzato sotto casa a Genova. L'amministratore delegato della Ansaldo
Nucleare, multinazionale generosa dispensatrice di tumori e
radiottività, è crollato a terra sul selciato di via Montello, alle 8,30
del mattino. Non un infarto, non un incidente, ma una pallottola lo
costringerà forse a zoppicare per il resto della vita. È probabile che
egli sopravviverà assai più a lungo delle vittime provocate dal suo
lavoro.
Il ferimento di Adinolfi ha fatto notizia su tutti i media del
paese, ma soprattutto i suoi colleghi, i suoi datori di lavoro e qualche
suo dipendente lo hanno compianto. La stragrande maggioranza della
popolazione sembra non essersene nemmeno accorta, avendo ben altre
preoccupazioni. Se n'è accorto il movimento, invece, dove la politica si
annida, si radica e si espande sempre di più. Non sono mancati i
compagni che hanno iniziato a brontolare, a storcere il naso, a smorzare
ogni sorriso. E gli argomenti sono sempre gli stessi, identici a quelli
di quarant'anni fa: «Non ridete, non è merito della lotta di massa!»,
«Non brindate, è un pretesto per favorire la repressione!», «Non gioite,
sono stati i servizi segreti!». È sempre la solita cantilena,
immutabile nella sua tristezza: un vero e proprio invito alla
desistenza. In nome della politica, della strategia, della tattica —
tutte cose detenute dai vari racket militanti — si sollecita il biasimo
per il ferimento di uno dei più immondi manager di Stato. Evidentemente
l'idea che dei singoli individui possano uscire di casa, cercare il
nemico e colpirlo senza attendere la grande sera collettiva, continua ad
essere intollerabile. Si rischia di rendere superflui partiti e
assemblee, leader e comitati.
Un'azione anche questa che parla da sé, che non ha bisogno di
alcuna giustificazione e spiegazione. Ma il ferimento di Adinolfi ha
conosciuto il suo marchio di fabbrica, si è identificato con un logo.
Una rivendicazione è arrivata ai media ed è subito stata presa in
considerazione. Qui niente selva oscura, ma luci al neon accese al
massimo per illuminare la propria figura. Essendo esclusiva proprietà di
qualcuno, quella azione non potrà quindi appartenere a tutti.
A quarant'anni di distanza, i tempi sono cambiati? Ad ognuno le proprie scelte, a ciascuno le sue conclusioni...
http://www.finimondo.org/node/820